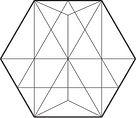Scavi archeologici di Ercolano
Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti.
Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini archeologiche ad Ercolano cominciarono nel 1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si interruppero nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927: la maggior parte dei reperti rinvenuti sono ospitati al museo archeologico nazionale di Napoli, mentre è del 2008 la nascita del museo archeologico virtuale che mostra la città prima dell'eruzione del Vesuvio.
Il sito di Ercolano, gestito dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, viene visitato mediamente da trecentomila turisti ogni anno: nel 1997, insieme alle rovine di Pompei ed Oplonti, è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.Nel 2013 è stato il quattordicesimo sito statale italiano più visitato, con 329 669 visitatori e un introito lordo totale di 1.680.954,90 Euro
Secondo Dionigi di Alicarnasso, Ercolano fu fondata da Eracle di ritorno dall'Iberia, mentre secondo una versione meno mitologica, riportata da Strabone, fu fondata dagli Osci[4] su un promontorio tra due torrenti, ai piedi del Vesuvio, affacciata sul mar Tirreno. Fu quindi conquistata dagli Etruschi, dai Pelasgi, dai Sanniti per poi passare nell'alleanza romana, trasformandosi in un piccolo borgo fortificato con mura di modeste dimensioni. Durante le guerre sociali, Ercolano, così come le altre città della zona, si ribellò a Roma e venne quindi conquistata da Titius Didius, un legato di Lucio Cornelio Silla, nell'89 a.C., ottenendo nel 30 a.C. lo stato di municipio. Fu da questo periodo che si trasformò principalmente in un centro di villeggiatura, risentendo in misura sempre maggiore dell'influsso della vicina Neapolis, della quale può essere considerata un suburbio.
Durante l'età augustea furono realizzati importanti lavori urbanistici con la costruzione di nuovi edifici pubblici come le terme Suburbane e Centrali, la Palestra, il Teatro, e l'acquedotto con una serie di fontane pubbliche, grazie anche all'aiuto del tribuno Marco Nonio Balbo: nel periodo di massimo splendore, la città arrivò a contare circa quattromila abitanti distribuiti su circa venti ettari di territorio. Venne gravemente danneggiata dal terremoto del 62, tant'è che poco dopo Vespasiano finanziò il restauro della Basilica e del tempio.
Nel 79 fu infine interessata dalla famosa eruzione del Vesuvio, narrata da Plinio il Giovane, che distrusse anche Pompei, Oplonti e Stabia. Durante quest'evento, oltre alle ceneri e ai lapilli, che qui caddero in quantità minori rispetto a Pompei, a seguito di diverse colate piroclastiche, la città venne sepolta sotto una coltre di fango, che solidificandosi produsse uno strato di tufo spesso dai dodici ai quindici metri; il tufo ha conservato intatti, oltre agli edifici e agli oggetti, anche materiali organici come cibi e legno. Sul medesimo strato di tufo, nei secoli successivi, si sviluppò un nuovo centro abitato che prese il nome di Resina, cambiato nel 1969 in Ercolano.
Le esplorazioni nel XVIII secolo
Col passare dei secoli il ricordo dell'antica Ercolano andò sempre più affievolendosi, fino a svanire quasi del tutto; il suo ritrovamento avvenne per caso: nel 1710, un contadino di nome Ambrogio Nocerino, detto Enzechetta, durante lo scavo di ampliamento di un pozzo per l'irrigazione del suo orto, nei pressi della chiesa di San Giacomo e del bosco dei frati alcantarini, si imbatté in alcuni pezzi di marmo pregiato. Un artigiano al servizio dell principe Emanuele Maurizio d'Elboeuf, passando in quei luoghi per caso lì notò, e ne acquistò alcuni per realizzare delle cappelle in diverse chiese di Napoli: il nobile, venuto a conoscenza dei ritrovamenti, acquistò il pozzo, e per nove mesi, fino al 1711, condusse una prima sommaria esplorazione tramite una serie di cunicoli sotterranei[4]; i reperti rinvenuti furono collocati nella vicina Villa d'Elboeuf. Come si verificò successivamente, lo scavo del pozzo aveva intersecato la scena del Teatro di Ercolano, erroneamente identificato all'inizio come il Tempio d'Ercole; comunque si intuì ben presto che le rovine appartenevano all'antica città scomparsa nell'eruzione del Vesuvio del 79. Gli scavi vennero poi interrotti per volere della magistratura che temeva possibili danni alle abitazioni soprastanti: durante la prima esplorazione, che aveva riguardato la scena, il palcoscenico e un lato dei tribunalia del teatro, furono rinvenuti colonne in marmo africano, in alabastro ed in giallo antico, un architrave inneggiante ad un console del 38 a.C., Claudius Pulcher, dolia in terracotta e nove statue, otto di donna ed una di un uomo nudo, in posizione eroica, alcune ancora in piedi all'interno delle loro nicchie; alcune di queste, dopo aver adornato il palazzo del Belvedere di Vienna, sono oggi esposte alla Skulpturensammlung nell'Albertinum di Dresda, mentre le altre furono sistemate all'interno della Reggia di Portici,
Nel 1738, durante la costruzione della Reggia di Portici, voluta da Carlo di Borbone, un funzionario di questi, Rocque Joaquin de Alcubierre, incaricato di tracciare una mappa della zona, venne a conoscenza dei ritrovamenti di un quarantennio prima: ottenuto il permesso dal re, insieme a pochi operai iniziò una nuova esplorazione, ed anche in questo caso furono rinvenuti statue, pezzi di marmo e frammenti di iscrizioni e cornici; un erudito dell'epoca, Marcello Venuti, che lavorava alla corte nell'ambito della sistemazione della biblioteca e della galleria Farnese, intuì che i reperti provenivano dal teatro e non dal Tempio di Ercole. Nel 1738 fu data alle stampe la prima mappa del sito di Ercolano, perfezionata poi nel 1747, mentre nel 1748 venne pubblicata la prima opera sulle scoperte di Ercolano, dal titolo Descrizione delle prime scoperte dell'antica città di Ercolano, scritta da Ottavio Antonio Bayardi. Nel 1750 si affiancò ad Alcubierre anche Karl Weber, il quale studiò a fondo il teatro e i suoi meccanismi di funzionamento, riportando alla luce una nuova statua in bronzo; dello stesso ingegnere svizzero fu l'idea nel 1760 di condurre uno scavo a cielo aperto, visto che le esplorazioni per cunicoli collegati a pozzi di discesa e pozzi di aerazione, oltre a essere molto scomode in quanto le dimensioni dei cunicoli talvolta non superavano i cento centimetri di larghezza per un'altezza massima di un metro ed ottanta, soffrivano di una scarsa illuminazione e comportavano il pericolo di crolli e di ristagno di gas velenosi: a tale proposta si dissero favorevoli sia Luigi Vanvitelli che Ferdinando Fuga[8], mentre contrario fu Alcubierre, il quale era in forte opposizione con tutto l'operato del collega, motivando la propria opposizione col timore, in caso di terremoto, di possibili crolli dei palazzi circostanti la zona degli scavi; l'idea fu definitivamente abbandonata a seguito della morte prematura di Weber nel 1764Precedentemente, nel 1760, lo svizzero aveva scoperto casualmente la Villa dei Papiri, con un carico di statue ed oltre mille papiri carbonizzati; ciò non fece altro che accentuare l'interesse per Ercolano, tanto che nel 1755 venne inaugurata l'Accademia Ercolanese per lo studio del sito, mentre nel 1751 tutti i reperti rivenuti vennero trasferiti nella Reggia di Portici, trasformata in un vero e proprio museo visibile solo al re e ai suoi ospiti: prima del termine della costruzione della reggia, i reperti erano ospitati all'interno del palazzo Caramanico, integrato poi nella nuova costruzione. Nel 1768 si affiancò ad Alcubierre Francisco La Vega, il quale iniziò una nuova esplorazione del teatro e tramite l'utilizzo di una pompa idraulica per rimuovere l'acqua piovana in eccesso, raggiunse il piano di calpestio della terrazza dietro la scena, ad una profondità di quasi dieci metri sotto il livello del suolo: nel 1771 presentò inoltre una pianta dettagliata dell'edificio, seguita poi da altri disegni andati quasi tutti perduti. A partire da questo periodo però l'interesse per Ercolano andò scemando a causa del ritrovamento di Pompei, la quale presentava una modalità di scavo molto più semplice, trattandosi per lo più della rimozione di ceneri e lapilli, e offriva comunque una maggiore quantità di opere e reperti: nel 1780 le indagini ad Ercolano cessarono definitivamente.
Le esplorazioni tra il XIX ed il XXI secolo
Sull'onda del successo degli scavi di Pompei, nel 1828, sotto Francesco I delle Due Sicilie, ripresero le ricerche anche ad Ercolano: in questa nuova fase cambiò anche la tecnica esplorativa, passando dai cunicoli agli scavi a cielo aperto; tuttavia si contarono solo pochi ritrovamenti e i lavori vennero interrotti nel 1855. Nuovamente a partire dal 1869, sotto la direzione di Giuseppe Fiorelli, ci fu una breve campagna di indagini, inaugurata da Vittorio Emanuele II, ma per lo stesso motivo della precedente, venne sospesa nel 1875: la piccola area scavata, protetta da possenti muraglioni, era però sempre più minacciata dall'avanzare della moderna città di Resina, e nel 1904 l'archeologo statunitense Charles Waldstein, propose al governo italiano una cordata internazionale per effettuare nuovi scavi, ma la proposta, vista come lesiva per il prestigio dello Stato, venne rifiutata.
Con la nomina a capo della Soprintendenza agli Scavi ed alle Antichità della Campania nel 1924 di Amedeo Maiuri, venne attuato un programma di espropri al fine di evitare ulteriori danni e proteggere le rovine di Ercolano dalla forte espansione edilizia; il 16 maggio 1927 inoltre, partì una nuova campagna di scavi, che fino al 1942, quando si interruppe, grazie alla rimozione di oltre duecentocinquantamila metri cubi di tufo riportò alla luce circa quattro ettari dell'antica città: si tratta del parco archeologico visibile ancora oggi. Dal termine della guerra fino al 1958 si provvide alla messa in sicurezza ed al restauro di tutto il patrimonio architettonico rinvenuto; l'idea del Maiuri fu quella di realizzare una sorta di museo a cielo aperto; gli edifici appena rinvenuti, grazie ad un team di archeologi, muratori e giardinieri, venivano subito avviati a restauro: impresa questa non sempre semplice in quanto, a seguito dell'urto subito dalle colate di fango durante l'eruzione del 79, molte costruzioni si trovarono nella paradossale situazione di avere i piani inferiori fortemente danneggiati, e quelli superiori praticamente intatti, a ciò si aggiungevano i danni provocati dai cunicoli scavati durante il periodo borbonico, i quali avevano fortemente indebolito le strutture. In un secondo tempo, tutte le pitture venivano restaurate, mentre i reperti venivano esposti in varie teche: tuttavia l'esperimento durò solo pochi anni; in seguito, sia per l'elevato costo di manutenzione, dovuto soprattutto agli agenti atmosferici che interferivano con i materiali organici carbonizzati deteriorandoli, sia per il crescente turismo e per la possibilità di furti, quasi tutte le teche vennero smantellate.
Dopo una nuova breve campagna tra il 1960 ed il 1969, fu a partire dal 1980, sotto la direzione di Giuseppe Maggi, che vennero alla luce importanti novità sulla storia di Ercolano. Si era infatti ritenuto, fino a quel momento, che la popolazione della città, risparmiata in un primo momento dalla furia eruttiva, fosse riuscita a mettersi in salvo, ipotesi suggerita dal ritrovamento di pochi scheletri nell'ambito della cerchia urbana. Nuove indagini, condotte con l'ausilio di idrovore nei pressi della linea di costa del 79, consentirono di individuare, il 16 gennaio 1981, un primo gruppo di scheletri, ammassati al di sotto di alcune arcate che sostenevano la terrazze delle Terme Suburbane e dell'Area Sacra ed utilizzate per la manutenzione ed il ricovero delle imbarcazioni, oltre ad una barca. Negli anni successivi furono recuperati altri resti umani, per un totale di oltre trecento individui, il che portò gli archeologi alla conclusione che la maggior parte della popolazione di Ercolano avesse cercato la fuga via mare, sostando sulla spiaggia durante la notte, dove venne sorpresa dalle colate piroclastiche. Altre brevi indagini furono svolte nel 1988 e tra il 1996 ed il 1998: durante questi anni, precisamente nel 1997, gli scavi di Ercolano, insieme a quelli di Pompei ed Oplonti, entrarono a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Tra il 2002 ed il 2006 sono stati raggiunti nuovi ambienti della Villa dei Papiri: dal 2001 inoltre è attivo il programma Herculaneum Conservation Project che mira alla conservazione e alla valorizzazione del sito, oltre che alla realizzazione di nuove campagne di scavo.