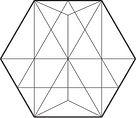Canzone napoletana
Con l'espressione canzone napoletana si identifica la musica popolare originaria di Napoli.
Il repertorio che va dagli inizi dell'XIX secolo all'immediato secondo dopoguerra, costituisce invece la canzone classica napoletana ed essa rappresenta uno dei punti d'eccellenza della canzone italiana, divenuti nel corso degli anni simbolo dell'Italia musicale nel mondo. I brani del periodo sono stati interpretati nel corso del tempo da numerosi interpreti di fama mondiale i quali hanno contribuito alla diffusione della canzone napoletana. Si ricordano Enrico Caruso, Roberto Murolo, Plácido Domingo, José Carreras, Renato Carosone, Mina, Renzo Arbore, Mia Martini, Luciano Pavarotti e tanti altri.
Nonostante sia una musica popolare, quindi di tradizione orale, secondo alcuni musicologi appartiene eccezionalmente alla musica popolare.
Storia
Origini
L'origine della canzone napoletana si colloca intorno al XIII secolo, quindi ai tempi della fondazione dell'Università partenopea istituita da Federico II di Svevia (1224), della diffusione della passione per la poesia e delle invocazioni corali dalle massaie rivolte al sole, come espressione spontanea del popolo di Napoli manifestante soprattutto la contraddizione tra le bellezze naturali e le difficoltà oggettiva di vita; si sviluppò già nel XV secolo quando la lingua napoletana divenne la lingua ufficiale del regno e numerosi musicisti, ispirandosi ai cori popolari, iniziarono a comporre farse, frottole, ballate, e ancora maggiormente dalla fine del Cinquecento, quando la "villanella alla napoletana" conquistò l'Europa, sin alla fine del Settecento. Questa espressione artistica popolare era allora carica di contenuti positivi ed ottimistici e raccontava la vita, il lavoro ed i sentimenti popolari.
Il XVI e la villanella
In particolar modo la "villanella alla napoletana" rappresentò un primo antefatto fondamentale per gli sviluppi della canzone napoletana ottocentesca, sia per la sua produzione originariamente popolaresca ben accolta dalla classe colta, sia per il suo carattere scherzoso e l'ampio spettro componentistico, che variava dalla polifonia all'accompagnamento strumentale per una sola voce. La più famosa villanella è probabilmente Si li femmene purtassero la spada.
Il XVII e il XVIII
Il Seicento vide sfiorire la villanella ed apparire i primi ritmi della tarantella, con la celebre Michelemmà, che pare addirittura ispirata da una canzone di origine siciliana, ma comunque attribuita al poeta, musicista, pittore, incisore ed attore Salvator Rosa. Nel secolo successivo si rintraccia un secondo antefatto della canzone napoletana ottocentesca, rappresentato sia dalla nascita dell'opera buffa napoletana che influenzò non solo il canto ma anche la teatralità delle canzoni, sia per le arie dall'opera seria che divennero un faro per la produzione popolaresca. Intorno al 1768 autori anonimi composero Lo guarracino, divenuta una delle più celebri tarantelle, rielaborata come molte altre canzoni antiche nel secolo seguente.
Gli anni settanta
Tramontato il Festival, e chiusa la stagione del repertorio classico, la canzone napoletana si adegua alle esigenze del tempo, vengono ripresi ed attualizzati i temi della sceneggiata; Mario Merola, pur rimanendo legato alla canzone tradizionale, è il principale interprete di questa nuova tendenza, seguito da Pino Mauro, Mario Trevi e Mario Da Vinci.
Parallelamente a questo fenomeno, Bruno Venturini rilegge in chiave lirica i più famosi brani del repertorio classico della canzone napoletana, dando vita ad una significativa opera antologica (con brani che vanno dal 1400 ai giorni nostri), nella continuità del bel canto italiano nel mondo, che ha avuto nel grande tenore Enrico Caruso la sua massima espressione vocale. Intanto il fermento musicale di quell'epoca è avvertito anche da nuovi autori come Eduardo De Crescenzo, Alan Sorrenti, Enzo Gragnaniello e Pino Daniele che daranno un'impronta nuova alla musica partenopea, seppur con musicalità diverse. Proprio quest'ultimo, scrisse nel 1977 alcune delle più famose canzoni napoletane successive al secondo dopoguerra: Napule è, Terra mia, Je so' pazzo e Na tazzulella 'e cafè.
Ancora in questo periodo, nascono gli Osanna, che percorrono la strada delle opere rock, e Napoli Centrale con James Senese, i quali intessono una interessante fusione di generi.
Gli anni ottanta
La sceneggiata napoletana che Mario Merola era riuscito a resuscitare negli anni settanta pian piano sparisce di nuovo, anche se tenuta in vita per un certo periodo da Nino D'Angelo, venendo sostituita dalla musica neomelodica che ancora oggi in tutto il Sud Italia, particolarmente nelle città di Napoli e Palermo e tra gli emigranti italiani all'estero, ha un discreto successo. Il personaggio che inventò questo genere musicale fu Nino D'Angelo che in questi anni vende milioni di dischi in tutto il mondo e approda sui palcoscenici più importanti Olympia di Parigi, al Madison Square Garden, nello stadio inglese di Wembley e tante altre tappe di importante rilevanza.
Nel 1986, Lucio Dalla scrisse una delle canzoni più importanti della sua vita musicale ed una delle più vendute ed interpretate della musica italiana: Caruso.
XXI secolo
I primi anni 2000 sono quelli in cui il genere musicale con lasciti arabi creato da Nino D'Angelo, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta continua ad avere molto seguito in ambito locale o più in generale nel sud Italia (prima fra tutte la Sicilia).
Da quest'ultima si sono formati molti nuovi interpreti di musica neomelodica, quest'ultima giudicata molto male dalla critica ufficiale, i cui esecutori però non sono conosciuti a livello nazionale, ma solo locale. A livello nazionale la seconda generazione di cantanti neomelodici è rappresentata in primis da Gigi D'Alessio e Gigi Finizio, noti però già negli anni novanta. Definita neomelodica, talvolta è legata strettamente alla criminalità organizzata.
Per quel che riguarda il repertorio classico della canzone napoletana, riconducibile agli anni che vanno dagli inizi dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, vede mantenuta stabile la sua rilevanza sullo scenario musicale internazionale grazie alle interpretazioni eseguite dai più grandi tenori del XX secolo, come Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo e Andrea Bocelli, i quali, in più occasioni, hanno tenuto concerti ed esibizioni che rimembrassero le antiche e tradizionali canzoni partenopee.
Non mancano artisti che, sul solco della tradizione classica, innovano la musica napoletana con composizioni interamente originali, tenendosi lontani dal basso stile neomelodico: musical come C'era una volta...Scugnizzi, cantautori come Sal da Vinci, gruppi come la Nuova Compagnia di Canto Popolare o i già citati Almamegretta.
Il tutto testimonia come, anche senza considerare i neomelodici, con 500 anni di storia la canzone napoletana sia ancora viva e attuale e rappresenti uno dei massimi vanti della città partenopea nel mondo.
Strumenti
Gli strumenti classici della canzone napoletana sono:
-
Mandolino
-
Chitarra
-
Calascione (nome assunto dal liutaio Calace) una sorta di antesignano del moderno basso
-
Triccheballacche, uno strumento a percussione in legno e piattini in alluminio
A questi si aggiungono tamorre (specie di tamburi) e tamburelli, caccavella o putipù, "Castagnelle" (nacchere) ed altri strumenti di fattura spesso artigianale.
Cantanti Napoletani




Renato Carosone
T'è piaciuta
Renato Carosone
Mambo Italiano
Clip Name
A città 'e Pulecenella
Tarantella Napoletana
Renato Carosone
Chella lla'
Clip Name
A Rumba de' Scugnizzi
Renato Carosone
O sarracino
Enrico Cannio
O' Surdato Nnammurato
Renato Carosone
Tu Vuò Fa' L'Americano
Scugnizza
Perzone perzone
Renato Carosone
O sole mio
Renato Carosone
Torero
Chi vo ben 'a Maronn 'e l'Arc
Claudio Villa
Mala Femmena
Roberto Murolo
Reginella
Renato Carosone
Pigliate 'Na Pastiglia
Roberto Murolo
Cu' mme
Claudio Villa
Io Te Vurria Vasa
Roberto Murolo
Luna Rossa
Ernesto de Curtis
TORNA A SURRIENTO
Clip Name
Tammurriata Nera
Renato Carosone
Caravan Petrol
Franco Corelli
Torna a Surriento
Claudio Villa
Funiculì funiculà
Renato Carosone
Io Mammeta e Tu
Gaetano Spagnolo
Rundinella
Roberto Murolo