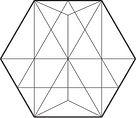Napoli sotterranea
Cenni storici sulle cavità napoletane
I primi manufatti di scavi sotterranei risalgono a circa 5.000 anni fa, quasi alla fine dell'era preistorica.
Successivamente, nel III secolo a.C., i Greci aprirono le prime cave sotterranee per ricavare i blocchi di tufo necessari alle mura e ai templi della loro Neapolis e scavarono numerosi ambienti per creare una serie di ipogei funerari.
Lo sviluppo imponente del reticolo dei sotterranei iniziò in epoca romana: i romani infatti in epoca augustea dotarono la città di gallerie viarie (grotta di Cocceio e grotta di Seiano) e soprattutto di una rete di acquedotti complessa, alimentata da condotti sotterranei provenienti dalle sorgenti del Serino, a 70 km di distanza dal centro di Napoli. Altri rami dell'acquedotto di età augustea arrivarono fino a Miseno, per alimentare la Piscina mirabilis, che fu la riserva d'acqua della flotta romana.
Larghi quel poco che permetteva il passaggio di un uomo, i cunicoli dell'acquedotto si diramano spesso in tutte le direzioni, con lo scopo di alimentare fontane ed abitazioni situate in diverse aree della città superiore. A tratti, sulle pareti, si notano ancora tracce dell'intonaco idraulico, utilizzato dagli ingegneri dell'antichità per impermeabilizzare le gallerie.
Agli inizi del XVI secolo il vecchio acquedotto e le moltissime cisterne pluviali non riuscivano più a soddisfare il bisogno d'acqua della città che si era estesa a macchia d'olio e fu così che il facoltoso nobile napoletano Cesare Carmignano costruì un nuovo acquedotto.
Fu solo agli inizi del XX secolo che si smise di scavare nel sottosuolo per l'approvvigionamento idrico e si abbandonò una rete di cunicoli e cisterne di oltre 2.000.000 m², diffusa per tutta la città.
I sotterranei furono utilizzati anche come rifugi antiaerei per proteggersi dai disastrosi bombardamenti che colpirono la città.
Le cavità furono illuminate e sistemate per accogliere decine e decine di persone che al suono della sirena si affrettavano a scendere per le scale che scendevano in profondità. Resti di arredi, graffiti e vari oggetti in ottimo stato di conservazione testimoniano ancora oggi la grande paura dei bombardamenti e i numerosi periodi della giornata vissuti nei rifugi, facendo riemergere uno spaccato di vita importante e altrettanto tragico della storia cittadina. È visibile uno di questi rifugi in via Sant'Anna di Palazzo, a Chiaia.
Al giorno d'oggi vi sono diversi percorsi per poter accedere alla rete di ambienti sotterranei, la quale non è ancora completamente conosciuta, in cui si alternano tra cisterne e cave, cunicoli e pozzi, resti del periodo greco-romano e catacombe, ed i passaggi che collegano svariati punti della città anche distanti chilometri sono innumerevoli. Ancora oggi speleologi continuano a studiare ed ispezionare le cavità e i cunicoli che riaffiorano in occasione di sprofondamenti e/o crolli ed inserirle nel cosiddetto censimento delle cavità cittadine.