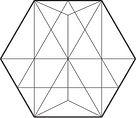Gli scavi archeologici di Stabia
Gli scavi archeologici di Stabia hanno restituito i resti dell'antica città di Stabiae, nell'area dell'odierna Castellammare di Stabia, presso la collina di Varano, oltre a un insieme di costruzioni che facevano parte del suo ager. La campagna di scavi iniziò nel 1749, durante il regno di Carlo di Borbone tramite cunicoli, mentre per delle indagini ordinate e sistematiche a cielo aperto bisognerà attendere il 1950, anno a partire dal quale fu centrale l'opera del preside Libero D'Orsi.
Rispetto agli scavi di Pompei e di Ercolano, quelli di Stabiae sono di dimensioni più ridotte e offrono la possibilità di osservare un diverso aspetto dello stile di vita degli antichi romani: infatti, mentre le prime due località erano delle città, Stabiae, dopo un passato di borgo fortificato, era in epoca romana un luogo di villeggiatura, in cui furono costruite numerose ville residenziali finemente decorate e abbellite con suppellettili di inestimabile valore; non mancavano, tuttavia, ville rustiche.
Attualmente, solo una piccola parte dell'antica città è stata riportata alla luce: sono visitabili la Villa San Marco, Villa Arianna e il secondo complesso; certa è l'esistenza di altre ville, come quella denominata del Pastore o di Anteros ed Heraclo, ancora parzialmente o completamente interrate, mentre altre ancora sono totalmente inesplorate: nella zona dell'Ager Stabiano (così veniva chiamato all’epoca dai romani il territorio che ricadeva sotto l'influenza di Stabiae e che comprendeva oltre alla cittadina stabiana anche i territori degli attuali comuni di Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Gragnano, Casola di Napoli e Lettere), sono presenti una cinquantina di costruzioni tra ville d'otium e ville rustiche.
Il sito di Stabiae registra mediamente ogni anno circa trentamila visitatori: per dare un nuovo impulso turistico al sito sia il comune, che diverse fondazioni, come la Restoring Ancient Stabiae (RAS), hanno proposto progetti per la realizzazione di un parco archeologico e di un museo che possa raccogliere le opere, le suppellettili e quant'altro rinvenuto dagli scavi della collina di Varano. I reperti stabiani si trovano sparsi in diversi musei del mondo: la maggior parte è custodita al Museo archeologico nazionale di Napoli ed un'altra cospicua quantità è conservata a Castellammare di Stabia, nell'antiquarium stabiano, realizzato da Libero D'Orsi nei depositi di una scuola ed oggi chiuso al pubblico.
Storia
Sulle origini di Stabiae non si hanno date certe: la zona era sicuramente già abitata durante l'età del ferro, come testimonia il ritrovamento di alcune tombe. La realizzazione di un piccolo centro urbano si deve invece agli Osci che scelsero il territorio di Varano per la sua posizione strategica, data la vicinanza al mare e le fertili campagne circostanti.
In seguito fu abitata da Greci, Etruschi e Sanniti: questi ultimi scendendo dai monti dell'Irpinia e del Sannio occuparono la pianura campana e costituirono una lega tra le città vesuviane conquistate con capitale Nuceria Alfaterna; fu in questo periodo che Stabiae divenne una città fortificata e si provvide alla costruzione di un piccolo porto, che comunque non ebbe grande importanza, sopraffatto da quello di maggiori dimensioni di Pompei: la zona circostante al villaggio fu denominata Ager Stabiano.
I Sanniti mantennero il possesso del territorio fino al 308 a.C. quando i romani li sottomisero e imposero a molte città della Campania la condizione di alleato. Tra il 90 e l'89 a.C. Stabiae, Pompei ed altre città italiche si ribellarono al dominio dell'Urbe accusata di non riservare loro gli stessi privilegi che avevano, invece, i cittadini romani: fu questo a provocare la Guerra sociale. La reazione di Roma non tardò ad arrivare e anche Stabiae capitolò il 30 aprile dell'89 a.C. a seguito dell'assedio di Lucio Cornelio Silla: la città fu distrutta e mai più ricostruita come borgo fortificato. Grazie all'amenità delle terre, la bellezza del panorama e la ricchezza di acque la zona fu scelta dai romani per la costruzione di ville residenziali, finemente decorate e dotate dei maggiori comfort per l'epoca, come palestre, ambienti termali e, in alcuni casi, anche di una discesa diretta al mare. La zona fu colpita da un violento terremoto nel 62 e molte costruzioni rimasero lesionate o, in alcune casi, furono rase al suolo: non era ancora stata completata la ricostruzione che la mattina del 24 agosto del 79 un'improvvisa eruzione del Vesuvio seppellì Stabiae sotto una fitta coltre di cenere e lapilli.
Rispetto a Pompei ed Ercolano, dopo l'eruzione, la ripresa della vita a Stabiae fu alquanto immediata: tuttavia il tessuto urbano non si sviluppò più in collina, ma lungo la linea di costa, sfruttando la piana che si era formata a seguito dell'emissione di ceneri e lapilli e che diventerà poi il cuore dell'odierna Castellammare di Stabia.
I Borbone: l'inizio degli scavi
Gli scavi archeologici di Stabiae iniziano ufficialmente il 7 giugno 1749 con una spedizione di sette uomini con a capo l'ingegnere spagnolo Rocque Joaquin de Alcubierre e l'ingegnere svizzero Karl Jakob Weber per volontà di re Carlo di Borbone. In realtà i primi interessi nel condurre una campagna di scavi per riportare alla luce l'antica città vesuviana risalgono a un secolo prima, quando, verso la fine del XVI secolo, il vescovo Milante, senza troppo successo, aveva chiesto che venissero effettuate delle spedizioni proprio per recuperare le vestigia di Stabiae. Nel 1748 sull'onda del successo degli scavi che si stavano svolgendo a Ercolano, re Carlo decise di ritrovare Stabiae, disponendo di avviare una campagna di scavo che partì il 23 marzo dello stesso anno: seguendo la Tavola Peutingeriana, uno stradario dell'impero romano risalente al IV secolo, il sito dell'antica Stabiae era da ricercarsi a nord del fiume Sarno, presso la collina di Civita. Già dai prime esplorazioni vennero alla luce monete, statue, affreschi e addirittura uno scheletro umano: purtroppo però Rocque Joaquin de Alcubierre, direttore dello scavo, non aveva ancora capito che non si trattava di Stabiae, bensì di Pompei; la corretta interpretazione del sito avvenne soltanto quindici anni dopo, nel 1763, grazie al ritrovamento di un'iscrizione che faceva chiaramente riferimento alla Res Publica Pompeianorum.
Nonostante questo, il 7 giugno 1749 partirono gli scavi anche presso la collina di Varano, il sito della vera Stabiae, dove pochi anni prima erano riaffiorati diversi reperti. I primi risultati furono davvero sorprendenti: vennero esplorate la Villa San Marco e la Villa di Anteros ed Heraclo nel 1749, Villa del Pastore nel 1754, Villa Arianna nel 1757 e il secondo complesso nel 1762. La prima sessione di scavi terminò nel 1762 quando le attenzioni si spostarono sugli scavi di Pompei che offrivano maggior interesse: i reperti e degli affreschi ritrovati nelle ville stabiane furono portati alla Real Reggia di Portici, anche se, tra il 1806 e il 1834, vennero trasferiti al Real museo di Napoli. Si è spesso discusso sul comportamento degli ingegneri borbonici durante le esplorazioni, e di come praticassero enormi fori nelle pareti per creare vie d'accesso ad ambienti ancora sepolti, tenendo in poca considerazione l'inestimabile patrimonio sui cui lavoravano, e arrivando perfino a graffiare volontariamente affreschi non asportati al fine di evitare depredazioni al termine dello scavo.
Rocque Joaquin de Alcubierre, contrario alla chiusura dello scavo, scrisse molte lettere al ministro Bernardo Tanucci, chiedendogli il permesso di poter riavviare le esplorazioni presso l'antica Stabiae. Tra le tante, in una scritta il 10 settembre 1774, si legge:
« Io desiderarei che S.M. mi dasse il permesso di poter fare alcuna prova solo con pochi operaij nella vicinanza di quelli luoghi all'antica città di Stabia, dove io trovai in passato molte delle migliori cose che s'osservano nel Real Museo»
(Rocque Joaquin de Alcubierre)
La tenacia di Alcubierre fu premiata nel 1775 quando fu finanziata una seconda campagna di indagini, questa volta svoltasi a cielo aperto e concentrata nella parte occidentale della collina, nei pressi di Villa Arianna e del secondo complesso per poi estendersi poco dopo a tutto il costone; inoltre furono riportate alla luce parti di alcune villa rustiche, in particolare nel territorio di Gragnano, come Villa del Filosofo nel 1778, Villa Casa dei Miri, Villa Ogliaro, Villa Petrellune nel 1779, Villa Cappella degli Impisi nel 1780 e Villa Medici nel 1781. La seconda fase di scavo durò soltanto sette anni e si concluse nel 1782 quando si decise di abbandonare definitivamente le ricerche su Stabiae e dirottare gli uomini e l'armamentario su Pompei.
Nel corso del XIX secolo il sito di Stabiae fu quasi del tutto dimenticato a favore della vicina realtà di Pompei e soltanto verso la fine del secolo sembrò riaccendersi un piccolo interesse; tra il 1876 e 1879, a seguito dei lavori di costruzione della cappella di San Catello nella cattedrale di Castellammare di Stabia, furono rinvenuti alcuni reperti risalenti sia al periodo precedente sia a quello successivo all'eruzione: infatti, a una profondità di circa sette metri, si ritrovarono iscrizioni, segmenti di strade e soglie di abitazioni, mentre a una profondità di circa tre metri furono trovati colonne, sarcofagi, affreschi e un pezzo di muro appartenuto a una conceria di pelli. Probabilmente dopo l'eruzione del Vesuvio in questa zona fu ricostruita, come testimonia anche un cippo, la strada che collegava Nuceria Alfaterna con Sorrentum, sul cui ciglio sorgevano diverse necropoli come dimostrano, oltre ai ritrovamenti stabiani, anche altri più recenti nei pressi di Vico Equense. Altro elemento d'interesse verso Stabiae fu la pubblicazione nel 1881 da parte di Michele Ruggiero, direttore degli Scavi di Antichità del Regno d'Italia, di una raccolta che comprendeva diari di scavi, planimetrie, lettere e cartografie risalenti alle esplorazioni fatte alla fine del XVIII secolo.
Libero D'Orsi: la ripresa degli scavi
Il nuovo millennio si è aperto con la fondazione di una associazione onlus italo-americana chiamata Restoring Ancient Stabiae (RAS), che insieme alla collaborazione della Regione Campania e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia hanno elaborato un progetto per la creazione di un parco archeologico destinato a far conoscere le ville stabiane e, allo stesso tempo, a garantirne la manutenzione e l'esplorazione. A supporto di questo progetto è nato anche il Vesuvian Institute, un istituto internazionale per l'archeologia che svolge funzioni sia ricettive che di polo di ricerca per studenti e archeologi impegnati nei vari tirocini e stage offerti dall'istituto stesso.
Nel 2003, in seguito a violenti acquazzoni, parte del costone della collina di Varano è franata portando alla luce alcuni ambienti, anche di notevole fattura, di una domus romana: si trattava di una villa di cui si ignorava l'esistenza, nemmeno segnalata nelle mappe borboniche; non si è ancora accertato se si tratta di una villa d'otium oppure di una semplice casa dell'antico abitato di Stabiae, prima della distruzione da parte di Silla.
Il 2006 è un anno ricco di eventi: nel mese di giugno, a seguito di lavori di pulitura di una zona della collina di Varano sono stati riportati alla luce alcuni ambienti appartenenti alla Villa di Anteros ed Heraclo, costruzione già scoperta dai Borbone nel 1749 ma poi nuovamente seppellita ed andata perduta: purtroppo, a seguito della mancanza di fondi, lo scavo è stato nuovamente interrotto. Nel mese di luglio dello stesso anno, campagne di scavo promosse dalla RAS hanno fatto riaffiorare il peristilio superiore di Villa San Marco, con l'individuazione dell'angolo estremo, grazie alla presenza di una colonna angolare sempre in stile tortile: nelle vicinanze della colonna è stato ritrovato anche il primo scheletro umano di Stabiae, probabilmente un fuggiasco rimasto vittima di un crollo; alle spalle del peristilio vennero scoperti anche tre cubicula. Queste scoperte hanno richiesto diversi anni di studio e indagini, effettuati con alcune tecniche all'avanguardia, non invasive del territorio, come l'utilizzo di magnetometri e georadar
Nel 2008 sia Villa San Marco che Villa Arianna sono state interessate da esplorazioni che hanno riportato alla luce, nella prima villa, una serie di cubicula, due latrine e un giardino dove era posta l'entrata secondaria, mentre nella seconda è stato scoperta parte del grande peristilio che all'epoca romana affacciava direttamente sul mare. Nonostante però l'impegno delle diverse associazioni, spesso sono stati lanciati allarmi di denuncia nei confronti della poca manutenzione e pubblicizzazione del sito stabiano; altro aspetto negativo è la mancanza di un'adeguata sede per l'antiquarium stabiano, chiuso ormai da molti anni. Si è discusso su vari progetti che prevedono lo spostamento del museo o presso la Reggia di Quisisana o presso un ex convento di suore stimmatine, ma poco è stato fatto fino a oggi. In tal senso qualcosa si è messo in moto nel mese di giugno del 2008 con l'apertura del Museo diocesano sorrentino-stabiese, ubicato presso la chiesa dell'Oratorio a Castellammare di Stabia e che conserva numerosi reperti provenienti dalla necropoli sotterranea della cattedrale stabiese come lapidi, colonne, capitelli e suppellettili, ma anche reperti più recenti risalenti all'epoca rinascimentale: il museo ha riscontrato subito un buon successo di pubblico, toccando quota duemila visitatori nel giro di pochi mesi. Sempre a sostegno di una campagna di rilancio degli scavi stabiani è stato organizzato nell'estate 2008 a Villa San Marco uno spettacolo canoro del cantante Lucio Dalla.
Nel 2009 nuovi scavi hanno riportato alla luce un'antica strada romana che corre lungo il perimetro settentrionale di Villa San Marco; si tratta di una strada lastricata che collegava il borgo di Stabiae con il lido sottostante: lungo tale arteria è presente in buone condizioni una porta di accesso alla città, la prima ritrovata, e lungo le mura sono disegnati una miriade di graffiti e piccoli disegni in carboncino. Dall'altro lato della strada è stato inoltre scoperto un quartiere termale di una nuova villa esplorata in parte in epoca borbonica. Nel corso dello stesso anno a Villa Arianna è riaffiorato un giardino considerato come il miglior conservato al mondo, mentre a Casola di Napoli, a pochi metri da una palazzina abusiva è riaffiorato un tratto di strada romana con l'ingresso ad una domus appartenente all'Ager Stabiano. Nel maggio 2010, durante i lavori per il raddoppio del binario della linea ferroviaria Torre Annunziata - Sorrento della Circumvesuviana, tra le stazioni di Ponte Persica e Pioppaino, è stata scoperta una villa risalente al I secolo: tra gli ambienti esplorati un reperto termale, un forno per la produzione di pane e diversi ambienti servili tutti finemente affrescati. Nel 2012, dopo due anni di lavoro, si sono concluse le opere di restauro delle ville sul pianoro di Varano, che hanno portato alla totale sostituzione delle vecchie coperture con nuove in legno, in modo da preservare maggiormente affreschi e mosaici ed alla sistemazione di copie delle pitture, nella loro posizione originale, asportate durante gli scavi borbonici e degli anni cinquanta
Gli scavi nel nuovo millennio
Nel 1950 Libero D'Orsi, preside di una scuola media di Castellammare di Stabia e appassionato di archeologia, assieme a pochi operai, con non poche difficoltà sia a causa dello scetticismo dei proprietari terrieri, sia per problemi economici, ottenne la possibilità di effettuare degli scavi archeologici sulla collina di Varano, dove due secoli prima i Borbone avevano riportato alla luce le antiche vestigia della città romana di Stabiae e dove alcuni anni prima, tra il 1931 e il 1933, in alcuni fondi agricoli erano riaffiorate parti di mura. Con l'aiuto delle mappe redatte durante gli scavi borbonici, a partire dal 9 gennaio 1950, vennero riportati alla luce alcuni ambienti di Villa San Marco e Villa Arianna e nel 1957 quelli di Villa Petraro, domus ritrovata per caso ma poi nuovamente interrata dopo alcuni anni di studio: le indagini procedettero per dodici anni fino a interrompersi definitivamente nel 1962 a seguito della mancanza di fondi; la notizia dei ritrovamenti archeologici fece in poco tempo il giro del mondo tanto che illustri visitatori, come Margherita d'Austria, la duchessa Elena d'Aosta, i reali di Svezia e gli ex sovrani della Romania, fecero visita alle rovine di Stabiae. Durante questi anni una grande quantità di reperti fu rinvenuta, così come alcuni degli affreschi ritenuti più importanti furono staccati per consentirne una migliore conservazione: i quasi novemila reperti raccolti furono ospitati presso alcuni locali seminterrati della scuola media Stabiae di cui Libero D'Orsi era preside; la possibilità di visitare questa mostra permanente è durata alcuni anni poi a causa del basso numero di visitatori, la scarsa campagna pubblicitaria e l'inadeguatezza dei locali ha portato l'Antiquarium stabiano alla chiusura in attesa di migliore collocazione.
La prolungata mancanza di fondi ha provocato un effetto di stasi negli scavi durante tutto il periodo che va dagli anni sessanta alle fine degli anni novanta: nonostante tutto, spesso per motivi piuttosto casuali, si sono rinvenuti numerosi resti di ville e necropoli come nel 1963, quando fu scavata Villa Carmiano, poi sotterrata, nel 1967 riaffiorò parte del secondo complesso e della Villa del Pastore, sotterrata nuovamente nel 1970, oppure nel 1974 quando fu scoperta una villa appartenente all'ager stabiano, ma situata nell'attuale comune di Sant'Antonio Abate e il cui scavo non è stato ancora del tutto ultimato: oltre a queste ville, altre, specie quelle rustiche, furono scoperte in tutto l'ager stabiano, in particolar modo tra Santa Maria la Carità e Gragnano; tutte, dopo una breve esplorazione furono nuovamente sepolte. Nel 1980 a seguito del violento terremoto dell'Irpinia del 1980 parte del colonnato tortile del peristilio superiore di Villa San Marco fu quasi totalmente distrutto, senza considerare gli ingenti danni che le ville subirono: l'evento causò la chiusura al pubblico degli scavi, riaperti soltanto dopo quindici anni. Nel 1981 gli scavi entrarono a far parte della neonata Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia che comprendeva oltre al sito stabiano anche gli scavi di Pompei, Ercolano e Oplontis e sempre nello stesso anno, a seguito di lavori di asportazione di lapillo, fu rinvenuto parte del cortile di Villa Arianna, all'interno del quale erano presenti due carri per uso agricolo, di cui uno restaurato e successivamente esposto al pubblico. Nel resto degli anni ottanta si è proceduto soltanto a interventi di manutenzione e restauro, così come negli anni novanta, eccetto pochi eventi importanti, come il ritrovamento di alcune sostruzioni presso Villa Arianna nel 1994, la riapertura del sito archeologico al pubblico nel 1995 e il recupero di alcuni ambienti della palestra di Villa Arianna nel 1997.